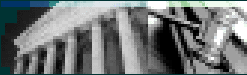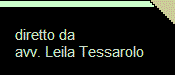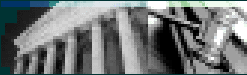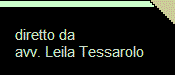|
|
I servizi pubblici locali tra novità legislative e iniziative degli enti territoriali*
Sommario: 1. Le novità introdotte dall’art. 23-bis e le categorie di problemi. – 2. I problemi di metodo. – 3. I rapporti tra fonti. – 4. I concetti di fondo. – 5. Gli assetti concorrenziali. – 6. Affidamenti multiservizi e bacini di gara. – 7. La tutela dei soggetti deboli. – 8. Le iniziative locali. In particolare: l’Autorità sui servizi pubblici locali del Comune di Genova.
1. Le novità introdotte dall’art. 23-bis e le categorie di problemi.
Anche il nuovo Governo, insediato da pochi mesi, non ha resistito alla tentazione di mettere mano al sistema dei servizi pubblici locali, intervenendo sulla disciplina generale con il famigerato art. 23-bis del decreto-legge n. 112, del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133, del 6 agosto 2008. La nuova disciplina riguarda i servizi pubblici locali “di rilevanza economica”. Ciò significa, da un lato, che non sono interessati quelli privi di rilevanza economica. Ma, soprattutto, che tutti i servizi a rilevanza economica sono oggetto della riforma contenuta nel pacchetto-Tremonti. Soffermandosi anzitutto su quest’ultimo profilo, è importante sottolineare che il 23-bis ha una vocazione universale e prevale sulle discipline di settore eventualmente difformi. Ciò desta non poche perplessità: le maggiori, forse, riguardano il trasporto pubblico locale, di recente oggetto del regolamento comunitario CE 1370/2007, applicabile dal dicembre 2009. Nonostante il regolamento (ovviamente prevalente sulla disciplina interna) contenga una dettagliata disciplina sull’affidamento del servizio e sui contenuti dei contratti di servizio, non viene mai richiamato dall’art. 23-bis. Si è accennato poco sopra che la riforma non tocca i servizi privi di rilevanza economica. Il punto, per gli addetti ai lavori, non desta particolare interesse, risolvendosi in un escamotage volto ad evitare censure di legittimità costituzionale relative alla competenza dello Stato. La sentenza n. 272 del 2004 della Corte costituzionale ha infatti chiarito che gli interventi legislativi dello Stato posono incardinarsi sulla competenza trasversale “tutela della concorrenza”, anche intesa in prospettiva promozionale, solo a condizione che i servizi siano a rilevanza economica, e dunque possibili oggetto di concorrenza tra operatori. E, su queste basi, la Corte aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 113-bis del Tuel, destinato alla disciplina dei servizi privi di rilevanza economica. Non si deve scordare, tuttavia, che sia i giudici italiani che quelli europei si sono progressivamente attestati su una concezione ‘potenziale’ di economicità, ritenendo cioè che abbiano tale caratteristica tutti i servizi che anche solo astrattamente siano suscettibili di un’organizzazione tale da generare profitti e –di conseguenza – appetiti concorrenziali (cfr. CGCE, C-180/98 e C-184/98, Pavlov, e CGCE C-475/99, Ambulanz Glöckner). Da ciò, pertanto, il sostanziale svuotamento della categoria dei servizi privi di rilevanza economica, che pure resta affidata alle cure del legislatore regionale.
Un altro aspetto preliminare, da mettere in luce, è che la riforma riguarda i soli servizi pubblici locali: restano pertanto esclusi i cd. servizi strumentali, per i quali sarà applicabile l’art. 13 della riforma Bersani (d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006). La precisazione, chiara sotto il profilo astratto, non mancherà di presentare controversie applicative, stante la perdurante incertezza dei confini tra concessione di servizio pubblico e appalto di servizi e, soprattutto, la materiale difficoltà di individuare caratteri trilaterali o bilaterali in relazione ad alcune categorie di servizi (si pensi, per fare gli esempi maggiormente discussi, alla cura del verde pubblico, o al riscaldamento degli edifici pubblici).
Sempre in riferimento alle prime battute dell’art. 23-bis, emerge il richiamo ai titoli che legittimano la competenza statale. In via generale, non sfugge la prassi, sempre più consolidata, di ‘motivare’ gli interventi normativi: la riforma costituzionale del 2001, cioè, ha spesso portato lo Stato ad inserire nelle disposizioni di legge il riferimento alle norme costituzionali che le legittimano, al fine di evitare contenziosi con le Regioni davanti alla Corte costituzionale, o, quantomeno, al fine di precostituire una giustificazione. Con più specifica attenzione alla disciplina di riforma dei servizi pubblici locali, invece, non sfugge che le competenze richiamate dalla normativa statale siano quelle previste dalle lettere e) ed m) dell’art. 117, c. 2, della Costituzione: si tratta, com’è noto, della tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Non compare, per contro, la lettera p), e cioè la determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, titolo che aveva suscitato accesi dibattiti in sede di discussione del disegno di legge Lanzillotta, nel quale era originariamente previsto, per poi essere espunto e, infine, reinserito. Anche sul riferimento alla lett. m) ci sarebbe da dire: la Corte costituzionale, infatti, nella già citata sent. n. 272 del 2004, ha precisato che la disciplina dei servizi pubblici locali “riguarda precipuamente i servizi a rilevanza economica e comunque non attiene alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni”. Del resto, se la materia rientrasse tra i livelli essenziali, non si capisce come potrebbe negarsi la competenza statale anche per i servizi privi di rilevanza economica, strettamente collegati ai diritti sociali cui fa riferimento la lett. m).
Ad una primissima lettura dell’articolato emergono alcuni elementi di fondo, oltre alla ormai consueta disattenzione per le regole di buon drafting. Limitandosi alle sensazioni più nette, si deve richiamare il generale favor per le procedure ad evidenza pubblica, il metus per la normativa comunitaria (il cui rispetto viene più volte enfaticamente richiamato, pur in modo del tutto pleonastico, ma testimone delle numerose passate ruggini con le istituzioni europee), nonché l’incompletezza della disciplina, che pone principi e regole la cui immediata operatività è assai limitata.
Questo breve contributo, anziché procedere ad una esposizione sistematica delle novità della riforma, ha come obiettivo l’individuazione delle principali categorie di problemi che affliggono la nuova normativa e le diverse previsioni che integrano le predette categorie di problemi. I prossimi paragrafi, pertanto, saranno dedicati all’analisi dei problemi di metodo, di quelli che toccano il rapporto tra fonti del diritto, di quelli sui concetti di fondo, di quelli più specificamente riguardanti la tutela e la promozione della concorrenza, di quelli che toccano gli affidamenti multiservizi e i bacini di gara, nonché i problemi che concernono la tutela dei soggetti più deboli, e cioè i lavoratori e gli utenti.
2. I problemi di metodo.
Sotto il profilo metodologico, emerge a prima lettura che l’art. 23-bis difetta di organicità, intrinseca ed estrinseca: se, infatti, da un lato, non contiene una disciplina completa della materia, dall’altro lato non contiene strumenti di armonizzazione con le discipline generali e settoriali esistenti. È stato efficacemente scritto (De Nictolis) che il 23-bis è una norma ‘extravagante’, poiché non contiene una novella dell’art. 113 del Testo unico sugli Enti locali, né si inserisce nel Codice dei contratti pubblici (e, segnatamente, dopo l’art. 30, dedicato alle concessioni di servizi in generale). La nuova disciplina, inoltre, pur avendo una vocazione sistematica, non contiene una normativa definitiva e non risolve alcuni tra i problemi di fondo che affliggono la materia. Si noti, ad esempio, che manca una definizione di cosa debba intendersi per servizio pubblico locale a rilevanza economica: si rinuncia, cioè, in radice, a delimitare il perimetro oggettivo di applicazione della nuova legge e a chiudere un dibattito che, di fatto, si trascina dalla legge Montemartini ad oggi.
Un ulteriore profilo critico riguarda la prospettiva ‘dinamica’, e cioè la procedura di approvazione della nuova normativa. Non può passare inosservata, infatti, la scelta del governo di inserire la riforma dei servizi pubblici locali nella manovra finanziaria estiva voluta dal ministro Tremonti e tradotta in un decreto-legge ‘omnibus’. La scelta, che sicuramente ha consentito di minimizzare gli ostacoli parlamentari e il dibattito pubblico, è nondimeno sorprendente, posto che i requisiti di urgenza sono assai dubbi e, soprattutto, non pare che – in questa legislatura – il governo abbia una maggioranza tanto debole da dover temere il confronto parlamentare. In base a queste considerazioni, quindi, sarebbe stato preferibile un disegno di legge, da presentare alle Camere e da approvare seguendo il procedimento legislativo ordinario. Una simile scelta, tra l’altro, avrebbe consentito un dialogo costruttivo con i diversi portatori di interessi e – soprattutto – con le parti sociali: circostanza tanto più importante in un settore come quello dei servizi locali, che tocca il destino di numerosissimi lavoratori.
Sorprende anche che le occasioni di confronto non vengano recuperate a valle, e cioè nel procedimento di adozione dei regolamenti delegati, cui l’art. 23-bis fa ampio riferimento. Il comma 10, infatti, oltre all’improprio richiamo della legge n. 400 del 1988 (di cui si dirà successivamente), si limita a prevedere che sugli schemi di regolamenti di delegificazione sia sentita la ‘Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281’, e cioè la Conferenza Stato-Regioni-Città, nonché le commissioni parlamentari competenti per materia. La previsione è senz’altro condivisibile, e si può considerare una concreta declinazione del principio costituzionale di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, faro del nuovo pluralismo istituzionale paritario. Manca, tuttavia, qualunque considerazione per gli stakeholders non-istituzionali, a cominciare proprio dalle parti sociali e dagli utenti dei servizi. Senza potersi in questa sede dilungare, è comunque da rimarcare come, di norma, la regolazione unilaterale stia lasciando il posto a forme di rulemaking procedimentalizzato, tali da garantire una maggiore rappresentanza degli interessi non pubblici, come testimoniano le prassi comunitarie dei libri verdi e dei libri bianchi.
Un ultimo problema di metodo, che si riprenderà anche nel paragrafo successivo, riguarda la generica previsione del primo comma per cui ‘le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili’. A questa disposizione si accompagna quella del comma 11, in base alla quale l’art. 113 del Tuel ‘è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo’. Sotto il profilo della tecnica legislativa, simili previsioni sostanziano tecniche di abrogazione anomale: la prima, infatti, contiene una norma abrogatrice tacita; la seconda, invece, una norma abrogatrice innominata. Entrambi i casi non contribuiscono alla chiarezza complessiva del sistema normativo, rimettendo all’interprete la concreta individuazione delle disposizioni e delle norme da ritenersi ormai prive di efficacia.
3. I rapporti tra fonti.
Uno dei nodi più intricati della nuova riforma dei servizi pubblici locali è quello del rapporto tra fonti. I problemi sono numerosi: anzitutto, come si è già ricordato più volte, l’art. 23-bis prevede espressamente la sua prevalenza sulle discipline di settore, forzando dunque il naturale percorso ermeneutico che porta la norma speciale precedente a prevalere sulla norma generale successiva. A prima vista il concetto di prevalenza dovrebbe integrare la necessaria abrogazione della normativa incompatibile. Questo risultato, tuttavia, sembra revocato in dubbio dalla lettera d) del comma 10, che demanda ai regolamenti delegati il compito di ‘armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua’. Non è chiaro in cosa consista questa armonizzazione ad opera dei regolamenti, posto che eventuali ‘disarmonie’ tra fonti legislative dovrebbero essere risolte – come detto – secondo l’istituto dell’abrogazione (nel caso specifico con prevalenza della disciplina contenuta nell’art. 23-bis).
Vi è un ulteriore profilo, di notevole complessità, che riguarda gli effetti della riforma e la competenza statale. Se infatti è vero che la nuova normativa prevale su quella settoriale incompatibile, a ciò consegue un possibile arretramento di alcuni settori sotto il profilo della concorrenza: si pensi al trasporto pubblico locale, ai rifiuti o al gas, dove l’art. 23-bis reintroduce la possibilità di affidamenti diretti, forzando le maglie delle attuali normative. Almeno in questi casi, pertanto, gli effetti della nuova disciplina sarebbero quelli di diminuire la concorrenza, anziché di aumentarla. Se questo è vero, si può dubitare della legittimità dell’intervento statale: l’art. 117, c. 2, lett. e), Cost., cioè la competenza trasversale in materia di tutela della concorrenza, può essere correttamente invocata solo quando l’intervento statale abbia l’effetto concreto di promuovere o di tutelare la concorrenza. È pur vero che, in via tendenziale, i titoli di legittimazione contenuti nell’art. 117 Cost. servono a separare le sfere di azione dei diversi legislatori. Ciò nondimeno, l’inversione di rotta del legislatore statale potrebbe prestare il fianco ad attacchi del legislatore regionale, quantomeno laddove questo abbia adottato discipline normative integrative di quelle statali precedenti. Il tema non può essere ulteriormente affrontato in questa sede, ma va segnalato come uno fra quelli che necessitano più attenta riflessione.
Lasciando il campo dei rapporti con il legislatore regionale, si deve notare che l’art. 23-bis si preoccupa anche di precisare i rapporti con il regolatore comunitario. Ciò, a ben vedere, appare superfluo, posto che il criterio di prevalenza del diritto comunitario non ha bisogno di espressi riconoscimenti legislativi, essendo stato ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale prima e dalla Costituzione poi. I primi commentatori (De Nictolis) della riforma hanno sottolineato come, semmai, sia significativa l’assenza di un richiamo ai principi del diritto interno e – in specie – a quelli di economicità, efficacia, tempestività, affermati dalla legge n. 241 del 1990. Sebbene sia sorprendente la diversa attenzione che il legislatore ha dimostrato nei confronti dei principi comunitari e di quelli interni, sembra tuttavia di poter concludere come sopra, e cioè nel senso del carattere pleonastico che avrebbe avuto l’ipotizzato richiamo alla legge sul procedimento amministrativo. Economicità, efficacia e quant’altro, infatti, si impongono sia in quanto derivabili dalla trama costituzionale, sia come principi generali riconosciuti costantemente dalla giurisprudenza (e, da questa, ricondotti sotto le ampie previsioni testuali dell’art. 97 Cost.).
Un’altra previsione problematica è quella contenuta nel comma 7 dell’art. 23-bis, in base alla quale ‘le Regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi’. Concentrando l’attenzione sulla competenza delle Regioni, non è da escludersi che leggi regionali, in base alla disposizione appena richiamata, intervengano per disciplinare i bacini di gara. È tuttavia da chiedersi se abbiano competenza sul punto. Il legislatore del 23-bis, infatti, ha effettuato – forse in modo non del tutto consapevole – una interessante costruzione: se, da un lato, l’intervento è stato giustificato proprio invocando l’esigenza di tutela della concorrenza, poi si è ‘delegato’ al legislatore regionale il compito di integrare la normativa statale, sebbene anche l’intervento regionale si dispieghi nel medesimo campo. Sul punto merita di essere richiamata la sentenza n. 29 del 2006 della Corte costituzionale, che ha ritenuto legittime le normative regionali in materia di servizi pubblici, laddove queste realizzino assetti maggiormente concorrenziali rispetto alla disciplina statale. La Corte, cioè, ha ricostruito la concorrenza quasi come un valore in sé, che fonda la competenza del legislatore di volta in volta intervenuto per tutelarla o promuoverla.
Con specifico riferimento alla previsione del 23-bis, invece, sembra quasi che venga creata una nuova competenza concorrente, immaginando un concorso vincolato di fonti non previsto dalla Costituzione. Nonostante questo interessante profilo ricostruttivo, che mette in luce le numerose zone grigie ancora presenti in riferimento al nuovo Titolo V, si può tuttavia giustificare la ‘delega’ statale anche in modo più piano: se infatti si pone attenzione al carattere trasversale della competenza di cui all’art. 117, c. 2, lett. e), Cost., riesce agevole concludere che l’intervento statale si spinge solo fintanto che lo Stato lo ritenga necessario. Con riferimento al caso specifico, la competenza regionale si riespande in materia di bacini di gara, posto che il legislatore statale ha ritenuto che non debbano avere una disciplina uniforme su tutto il territorio, ma che – anzi – questi possano meglio realizzare le esigenze del mercato ove costruiti in base alle specificità di ogni territorio.
Il problema appena affrontato presenta non pochi punti di contatto con quello di cui si dirà ora: la nuova normativa prevede come regola generale l’affidamento dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica, tuttavia non viene fornito alcun dettaglio su tali procedure, né si fa rinvio ai regolamenti delegati o ad altre fonti. Se dunque ci si domanda dove rinvenire le concrete procedure che sostanziano l’evidenza pubblica, si può prefigurare – come più sopra – una riespansione della competenza regionale e anche, verosimilmente, una competenza comunale, in applicazione del principio di sussidiarietà verticale. Se pertanto si immagina uno spazio comunale per dettare le regole di gara, e si immagina che i comuni più attenti vogliano dettare regole generali, applicabili a tutti i servizi, evitando improvvisazioni di bando in bando, la soluzione più probabile è quella di regolamenti comunali contenenti i principi per l’affidamento dei servizi pubblici locali. Simile ipotesi sembra, da un lato, espressione della sussidiarietà verticale. Dall’atro lato, però, pone non pochi problemi nei rapporti tra fonti, posto che si avrebbe un regolamento comunale in una materia in cui opera la competenza esclusiva statale. Non si dimentichi, inoltre, che proprio la Corte costituzionale, con la sentenza n. 401 del 2007, ha escluso la possibilità di interventi normativi regionali volti a disciplinare le procedure di gara.
Un ultimo punto critico posto dalla normativa di riforma riguarda i regolamenti di delegificazione, cui si fa ampio rinvio per completare la disciplina. Il comma 10 dell’art. 23-bis, che appunto disciplina lo strumento, richiama espressamente l’art. 17, c. 2, della legge n. 400 del 1988. Tale disposizione, com’è noto, ha per la prima volta inserito nel nostro ordinamento uno schema-tipo per i regolamenti di delegificazione, muovendosi sul delicato equilibrio tra esigenza di riduzione dell’ipertrofia legislativa e rispetto della costruzione gerarchica del sistema delle fonti (Sorrentino). Nonostante l’espresso richiamo allo schema-tipo, tuttavia, il legislatore del 23-bis detta poi un procedimento di adozione dei regolamenti di delegificazione del tutto difforme da quello previsto dalla legge n. 400 del 1988. La normativa di riforma, infatti, prevede che le norme di legge da ritenersi abrogate a far data dall’entrata in vigore dei regolamenti siano individuate dai regolamenti medesimi. Delegificazione, dunque, ma attuata mediante l’abrogazione di fonti primarie ad opera di fonti secondarie. L’art. 17, c. 2, della legge n. 400 del 1988, invece, prevede più prudentemente che le norme abrogate dal momento di entrata in vigore del regolamento siano individuate ex ante dalla medesima legge che autorizza l’adozione del regolamento di delegificazione (Sorrentino). Se pure, dunque, si possono immaginare le ragioni pratiche che hanno portato il legislatore del 23-bis ad adottare tale procedura, si deve stigmatizzare l’alterazione nel sistema delle fonti che pone verosimilmente i regolamenti previsti dal comma 10 in contrasto con il principio di legalità dell’azione amministrativa (e anche dell’esercizio della funzione regolamentare).
4. I concetti di fondo.
La riforma dei servizi pubblici locali sembra lasciare irrisolti alcuni dei problemi di fondo che affliggono la materia. In particolare, non viene chiarito il ruolo spettante agli enti locali, che possono essere al tempo stesso regolatori, proprietari e gestori di un servizio. Anzi, questa è ancor oggi la regola nella maggior parte dei comuni italiani. Qualunque riforma improntata alla liberalizzazione, e dunque ad aprire quanto più possibile i mercati dei servizi pubblici locali alla concorrenza tra diversi operatori, dovrebbe in primo luogo risolvere una delle ambiguità di fondo del modello italiano, e cioè il fatto che gli enti locali territoriali siano al tempo stesso controllori e controllati.
Le considerazioni appena esposte, che trovano a livello teorico una convergenza quasi unanime della dottrina e degli operatori, non hanno risposta nell’art. 23-bis, come ha sottolineato più volte l’Autorità antitrust, e da ultimo nelle osservazioni AS457 del 24 luglio 2008, proprio dedicate al progetto di riforma. Come nota il garante, le previsioni dell’art. 23-bis “non evitano il determinarsi di quelle situazioni di conflitto di interessi in capo agli enti pubblici controllori/azionisti dei gestori dei servizi pubblici”. Ad uno sguardo più attento, il legislatore della riforma mostra di essere ben consapevole del problema, ma evita di affrontarlo delegando ai regolamenti di delegificazione la “netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità” (così l’art. 23-bis, c. 10, lett. c). In attesa dei regolamenti, dunque, ogni soluzione è ipotizzabile. Fra le altre, è piuttosto suggestiva quella di portare anche il servizio idrico sotto il controllo e la regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, risolvendo così l’anomalia da più parti stigmatizzata che vede il servizio idrico privo di un’Autorità indipendente di riferimento, e rimesso alle cure delle Autorità territoriali d’ambito.
Ma, in attesa di ulteriori interventi normativi o dell’adozione dei regolamenti di delegificazione, è necessario concentrare l’attenzione sulla disciplina attuale. Come si è detto, l’art. 23-bis non risolve la natura anfibia degli enti locali e, di conseguenza, non detta una disciplina chiara in tema di reti, atta a garantire la neutralità della regolazione e della gestione delle stesse (Ammannati). Le previsioni in materia sono confinate nel comma 5 dell’art. 23-bis, che – ermeticamente – così dispone: “ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati”. Pur non essendo reso esplicito, è da ritenersi che nulla cambi circa la possibilità di reti in proprietà ai privati. La previsione del 23-bis, pertanto, deve interpretarsi nel limitato senso che le reti di proprietà pubblica non possono essere cedute. È invece importante l’apertura della gestione delle reti anche a privati. La norma, tuttavia, non precisa come debba avvenire l’affidamento, né contiene un’espressa disciplina sul riconferimento della rete al termine della gestione. E, più in generale, non contiene previsioni – che pure sarebbero state opportune – volte a garantire la neutralità della gestione delle reti, e dunque – in primo luogo – la trasparenza nell’accesso alla rete.
Fra le ambiguità del comma 5 vi è anche quella relativa alla possibilità di separare la gestione della rete dalla gestione del servizio. Se infatti si interpreta la disposizione nel senso di consentire una gestione privata della rete abbinata alla gestione del servizio, allora nihil novi. Se, per contro, si ritiene che il comma 5 consenta anche la gestione privata delle reti separata rispetto all’erogazione del servizio, la portata innovativa è senz’altro maggiore. Anche su questo, tuttavia, potrà essere fatta chiarezza dai regolamenti delegati.
Da quanto sin qui messo in luce emerge dunque – almeno sotto questo profilo – che l’art. 23-bis non riesce a risolvere alcuni dei problemi più urgenti nel settore dei servizi pubblici locali. Stante l’ambiguità e vaghezza delle previsioni normative si riespande lo spazio autonomo degli enti territoriali, in una concezione dinamica della sussidiarietà verticale. Proprio su questi profili di fondo vi sono alcuni esempi di particolare interesse. Tra tutti, l’istituzione di un’Autorità sui servizi pubblici locali da parte del Comune di Genova, di cui si dirà più in dettaglio nel paragrafo conclusivo.
5. Gli assetti concorrenziali.
Il principale obiettivo dichiarato dall’art. 23-bis è quello di aprire i servizi pubblici locali alla concorrenza. Ma quali sono i concreti passi in avanti che la nuova normativa consente? L’analisi della questione mette subito in luce la ‘detipizzazione’ delle modalità di affidamento. Con una scelta di drafting senz’altro originale, il legislatore non elenca più le possibili forme di affidamento, superando così le previsioni dell’art. 113 Tuel, e cioè gara, società mista e in house. Anche la durata degli affidamenti non è disciplinata, bensì è rimessa ai regolamenti delegati: la lett. h) del comma 10, infatti, dispone che i regolamenti prevedano “una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti”.
Concentrandosi sulle modalità di affidamento, l’art. 23-bis, al comma 2, si limita a prevedere che quello ordinario avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. Il successivo comma 3, invece, prevede che, in deroga alla modalità ordinaria, i servizi possano essere affidati “nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria”, e a patto che ricorrano “peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali, e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento” che non consentono il ricorso al mercato.
Limitandosi ad evidenziare i profili di maggior rilievo, emerge anzitutto che l’art. 23-bis fonda una precisa gerarchia tra la modalità ordinaria di affidamento e le altre che, appunto, sono in deroga. Questa considerazione, tuttavia, non risolve i problemi, dal momento che la ‘detipizzazione’ di cui si è detto prima non consente di individuare in modo certo quali siano le modalità di affidamento ordinarie e quali quelle derogatorie. Uno sguardo ai primi commenti dottrinari sulla riforma conferma i profili di incertezza: se alcuni hanno escluso che il 23-bis consenta ulteriori affidamenti in house (De Nictolis), altri hanno invece letto fra le maglie della normativa un’ampia possibilità di ricorrere a tipologie diverse dalla gara (Ammannati, ma anche la stessa Autorità antitrust, nelle osservazioni del 24 luglio 2008, ha raggiunto analoghe conclusioni), e altri ancora – dando per scontata la sopravvivenza di società miste e in house – si sono concentrati sulla collocazione delle diverse forme di affidamento tra le modalità ordinarie o derogatorie (Colombari).
Partendo dall’affidamento in house, non sembra che nell’art. 23-bis vi siano elementi certi volti ad escludere tale modalità di affidamento. Né è scontato – a ben vedere – che una simile ipotesi sarebbe compatibile con il diritto comunitario. Come emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti, il ricorso all’in house providing non è un’ipotesi anticoncorrenziale, ma una scelta di autoproduzione che ben legittimamente possono compiere gli enti titolari dei servizi. Proprio per questo motivo i giudici comunitari sono particolarmente attenti a fissare i confini entro i quali devono muoversi gli enti affidanti, al fine di evitare che l’in house providing sia utilizzato come strumento per aggirare le regole sulla concorrenza. Ciò è testimoniato dalla lunghissima catena giurisprudenziale che, dalla ormai ‘mitica’ sentenza Teckal, alla recentissima sentenza Coditel Brabant del 13 novembre 2008, ha scritto una sorta di mode d’emploi che lascia ben pochi margini alla fantasia elusiva delle amministrazioni locali. È tuttavia evidente che l’affidamento in house si colloca al di fuori dalle procedure competitive e, pertanto, rientra nella previsione in deroga di cui all’art. 23-bis, comma 3.
Decisamente più problematico è l’inquadramento delle società miste, ibrido creato da alcuni Paesi come partenariato pubblico-privato. Seguendo il più recente orientamento del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. II, parere n. 456 del 2007, nonché Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 2008) l’atto in sé dell’affidamento di un servizio a società mista avviene senza gara. A prima vista, pertanto, si dovrebbe ritenere che anche tale ipotesi rientri nelle modalità in deroga disciplinate dal comma 3. Ma è anche vero che il modello della società mista non è del tutto esente dal confronto concorrenziale: semplicemente sposta il momento in cui tale confronto avviene. Sempre aderendo alle ricostruzioni del Consiglio di Stato, infatti, l’affidamento di servizi pubblici a società miste è ammesso a condizione che il socio privato sia scelto con gara, che la partecipazione non abbia mero carattere finanziario (deve cioè trattarsi di un socio cd. operativo), che la durata della partecipazione sia predeterminata e limitata nel tempo, e che la gara abbia come specifico oggetto il tipo di servizio da svolgere e le modalità relative (con il conseguente divieto di società ‘generaliste’, ancorché costituite per gestire un unico servizio, come chiarito da Cons. Stato, n. 4862 del 18 settembre 2007). Qui interessa soprattutto il primo requisito, e cioè la necessaria scelta con gara del socio privato. A differenza di quanto immaginato dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, il Consiglio di Stato ha chiarito che la gara per la scelta del socio soddisfa i requisiti di confronto concorrenziale e dunque rende superflua una seconda gara per l’affidamento del servizio. Su questa base si può ben ritenere (Colombari) che l’affidamento a società miste non sostanzi una deroga alle procedure ad evidenza pubblica e, pertanto, sia da ricondurre alla previsione generale dell’art. 23-bis, comma 2. Questa soluzione, che a prima vista può sorprendere, ha anche il vantaggio di tutelare maggiormente gli azionisti delle società miste, che potrebbero lamentare una lesione del proprio affidamento in caso di eccessiva restrizione dei margini di operatività delle società medesime.
La corretta collocazione dell’affidamento dei servizi a società miste presenta dunque un rilievo determinante. Anche perché, come si vedrà subito, l’affidamento in deroga prevede non pochi vincoli. Spostando dunque l’attenzione sul terzo comma, si può preliminarmente notare come si parli di modalità di affidamento ‘in deroga’, e non di procedura di eccezione. La puntualizzazione può apparire di poco rilievo, ma in realtà segna il termine di un lungo percorso, incominciato al tempo della discussione sul disegno di legge Lanzillotta. A questo proposito può essere utile ricordare che la prima versione del ddl Lanzillotta confinava gli affidamenti a società miste e in house a ipotesi eccezionali. Nonostante ciò l’Autorità antitrust, nel parere del 28 dicembre 2006, criticava la vaghezza semantica di tale scelta, ritenendo che sarebbe stato preferibile inserire vincoli più stringenti già nella legge di delega. In prospettiva opposta, l’Anci, nell’audizione del 14 dicembre 2006, aveva ritenuto preferibile rafforzare i controlli degli enti locali sugli affidatari diretti, piuttosto che limitare in radice il ricorso a modalità di affidamento senza gara. La delicatezza nella scelta del termine si è puntualmente riproposta con l’approvazione dell’art. 23-bis. Nella sua comunicazione del 23 ottobre 2008, infatti, l’Autorità antitrust afferma che i vincoli comunitari “riconducono l’utilizzabilità dell’istituto dell’affidamento diretto ad ipotesi eccezionali”, dando dimostrazione di sposare un orientamento rigoroso e restrittivo.
Anche se l’Antitrust tace sul punto, l’interpretazione che lega le ipotesi di cui al terzo comma con i rigidi principi comunitari in tema di affidamenti in house sembra lasciar filtrare la convinzione che l’affidamento a società miste stia fuori dal disposto del comma 3. La Corte di giustizia, infatti, non si è mai pronunciata sulle società miste con socio privato scelto con gara, ma solo su ipotesi di affidamento in house illegittimo, dove si consentiva la partecipazione senza gara di soci privati a società a prevalenza pubblica. Se dunque (pur con qualche tentennamento) si può condividere che i casi in cui l’ordinamento comunitario consente l’affidamento in house sono “eccezionali”, ciò non si può dire per le ipotesi di affidamento a società miste, a condizione che il socio privato sia scelto con gara.
Ciò detto, è altresì da notare come ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario se ne aggiungano altri: come si è accennato, infatti, per il ricorso agli affidamenti in deroga è anche necessario che sussistano particolari condizioni “economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche”, che rendono impercorribile l’affidamento ordinario con procedura ad evidenza pubblica.
Oltre ad indicare i particolari requisiti oggettivi richiesti per gli affidamenti in deroga, l’art. 23-bis prevede anche una particolare procedura: il comma 4, infatti, dispone che l’ente territoriale intenzionato ad affidare in deroga debba dare adeguata pubblicità alla propria intenzione e che tale scelta sia supportata da un’analisi di mercato da trasmettere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, o ad altra Autorità indipendente settoriale competente. L’Autorità competente deve rendere un parere, obbligatorio ma non vincolante, entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione da parte dell’ente locale.
Questa complessa procedura, che riprende in parte quanto immaginato durante l’esame del disegno di legge Lanzillotta, pone più d’un profilo problematico. Sotto il profilo sostanziale, non lascia ben sperare la circostanza che il parere dell’Autorità indipendente sia l’unico argine amministrativo ad interpretazioni troppo estensive sugli affidamenti in house. Come ha puntualmente notato la stessa Autorità antitrust nelle osservazioni del 24 luglio scorso, il predetto parere rischia di essere troppo poco. Del resto è difficile pensare che un Tribunale amministrativo regionale, chiamato a valutare la legittimità di un affidamento in house, possa spingersi a sindacare la sussistenza – nel caso specifico – di quelle condizioni economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche che rendono legittima la deroga alle procedure ordinarie. È assai elevato, infatti, il rischio che la valutazione debordi nel merito delle scelte amministrative, e dunque esorbiti dalle competenze del Tar.
Sotto il profilo procedurale, invece, si deve nuovamente sottolineare che la richiesta del parere è obbligatoria, ma non vincolante. Se l’ente locale si discosta dal percorso tracciato dall’Autorità, deve ovviamente motivare la propria scelta. Ma qui ritornano le considerazioni appena espresse sui limiti al sindacato di merito del giudice amministrativo. Un ulteriore profilo da mettere in luce riguarda il momento temporale in cui il parere deve essere richiesto. La legge, infatti, non precisa che questo debba essere preventivo, lasciando ipoteticamente spazio anche a pareri richiesti dopo l’affidamento del servizio. Di diverso avviso sembra essere l’Autorità antitrust che, nella comunicazione del 16 ottobre 2008, prevede espressamente che l’ente locale “deve presentare una richiesta di parere … prima della delibera con la quale l’ente locale stesso affiderà il servizio ed in ogni caso, in tempo utile per il rilascio del prescritto parere”. Nonostante l’ipotesi teorica di pareri successivi – magari volti ad indirizzare le sorti di affidamenti già in essere – sembra da condividere l’interpretazione fornita dall’Antitrust, ed è da ritenere che nella prassi si consoliderà la richiesta di pareri in via preventiva. Ciò, tuttavia, non risolve il problema della scarsa cogenza giuridica di tali pareri, come si evince dalle parole della stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nella comunicazione appena richiamata, infatti, si afferma che “l’Autorità ritiene che l’ente locale è chiamato a tenere nella dovuta considerazione le valutazioni espresse nel parere rilasciato”. Questa precisazione, un po’ sorprendente, sembra confermare che l’opinione dell’Autorità garante ha maggiore possibilità di imporsi per la sua autorevolezza e per la sua capacità di moral suasion, che non per il peso specifico degli strumenti giuridici offerti dalla legge di riforma.
6. Affidamenti multiservizi e bacini di gara.
Passando ad analizzare alcuni profili di maggior dettaglio, ci si scontra sin dalla prima lettura con previsioni di rilievo sia in tema di affidamenti multiservizi che di bacini ottimali di gara. Il comma 6 dell’art. 23-bis prevede la possibilità di affidare simultaneamente più servizi “nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa”. È da segnalare la difficoltà di individuare criteri certi per tale “dimostrazione”, tanto che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nelle osservazioni del 24 luglio 2008, ha precisato che “andrebbero stabiliti dalla legge rigorosi criteri di considerazione e dimostrazione dell’effettivo vantaggio economico di tale scelta organizzativa”.
Ma è soprattutto importante sottolineare che la previsione normativa fa espresso riferimento ad affidamenti con gara. Questo sembra significare che gli affidamenti multiservizi non possono in nessun caso avvenire mediante le procedure in deroga previste dal comma 3. Più dubbia è la risposta con riferimento alle società miste: la legge parla di gara, e non di procedura ad evidenza pubblica. Un’interpretazione testuale, pertanto, dovrebbe escludere l’affidamento di più servizi ad una società mista. Ma il problema potrebbe essere più teorico che pratico, dal momento che – come si è detto nei paragrafi precedenti – le società miste (come immaginate dalle recenti pronunce del Consiglio di Stato) debbono avere una fisionomia tale da ridurre le possibilità di affidare più servizi diversi ad una medesima società.
La norma in questione rappresenta senz’altro un’innovazione nel panorama dei servizi pubblici locali, e favorisce l’emersione di economie di gamma. Tuttavia, com’è stato notato (Pozzoli), rischia di costituire un vantaggio per le sole imprese multiutilities, restringendo il mercato delle imprese mono-business, che pure dimostrano sovente ampie garanzie di efficienza. Questo aspetto problematico è stato evidenziato anche dall’Autorità antitrust che, nelle osservazioni del 24 luglio 2008, che ha suggerito “l’opportunità di prevedere la possibilità per le imprese di concorrere all’aggiudicazione anche di un solo distinto servizio tra quelli posti a gara”.
Una delle previsioni di più difficile interpretazione è poi quella del comma 7, che prevede in capo a Regioni ed enti locali la possibilità di definire “bacini di gara” per i diversi servizi. Il tema meriterebbe uno studio autonomo, e qui ci si limiterà ad alcuni cenni preliminari. Anzitutto si noti che la disposizione fa salve le normative settoriali. Una rigorosa interpretazione di questa previsione porta a concludere che solo per il trasporto pubblico locale vi siano spazi per definire i bacini di gara, restando esclusi tanto il settore idrico che quello del gas. Ma vi sono parecchie incertezze, e già si registrano le prime voci che immaginano il blocco degli ambiti territoriali minimi per le gare volte all’affidamento del servizio di distribuzione del gas, introdotti dalla legge n. 222 del 2007 (Ammannati). Senza soffermarsi ulteriormente sui rapporti tra bacini di gara e discipline settoriali, restano i dubbi sulla natura e sulla funzione di tali bacini. In particolare, non è chiaro quale sia l’assetto istituzionale dei bacini e se questi siano destinati a sciogliersi subito dopo l’effettuazione delle gare, ridistribuendo le competenze fra i diversi enti locali del territorio di riferimento.
Riservando un’ultima riflessione ai profili sostanziali, la norma immagina la definizione dei bacini di gara “in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento dei servizi, nonché l’integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale”. Anche questa disposizione non si segnala come esempio di drafting legislativo, né nella forma, né nella sostanza. Soffermandosi su quest’ultima, i margini di dubbio circa il significato della previsione sono notevolissimi. Il punto più problematico, tuttavia, sembra essere l’invito ad effettuare sussidi incrociati tra rami redditizi e rami non redditizi. È infatti difficile attribuire altra portata alla previsione di integrare “servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi”. E una simile interpretazione, com’è stato puntualmente notato (Pozzoli), pone seri problemi di legittimità in relazione con i principi concorrenziali che tendenzialmente vietano di sostenere attività non redditizie mediante i proventi di altri rami (la cd. cross-subsidiation).
7. La tutela dei soggetti deboli.
Un altro aspetto piuttosto sorprendente è dato dall’assenza di precisi riferimenti ai soggetti più deboli, cioè lavoratori e utenti. Si può giustificare il silenzio dell’art. 23-bis proprio in ragione della disorganicità della disciplina: la mancata previsione di nuove regole, cioè, lascia intatte quelle già in vigore. Simile considerazione è senz’altro vera, ma probabilmente si poteva e doveva fare di più. Il tema della tutela dei lavoratori, stigmatizzato dalle componenti sindacali, si risolve soprattutto nella mancata previsione di un bilancio sociale e nell’assenza di clausole sociali. Il tema del “bilancio sociale” è molto discusso e non è del tutto chiaro quali ne siano i contenuti. Certo, di norma, si intende bilancio sociale la predisposizione di processi aziendali condivisi, che coinvolgano tutti gli stakeholders e non solo gli organi sociali. Simile preoccupazione è senz’altro degna di essere considerata, ma difficilmente può trovare spazio all’interno di una disciplina relativa alle modalità di affidamento. Quanto invece alle cd. “clausole sociali”, è senz’altro vero che il settore dei servizi pubblici locali coinvolge un numero rilevantissimo di lavoratori e che una rapida apertura al mercato produrrebbe inevitabilmente esuberi e contrazioni dei posti di lavoro. Senza che questo intacchi le virtù della concorrenza, è comunque necessario che il legislatore e gli altri regolatori si prendano carico delle reali situazioni sociali, anche per scongiurare ipotesi di dumping sociale, e cioè il rischio che la concorrenza venga realizzata solo mediante il taglio dei costi, con conseguenti perdite di posti di lavoro.
L’altra categoria di soggetti deboli è quella degli utenti dei servizi. Il progressivo transito del sistema dei servizi pubblici locali nell’ambito del diritto privato societario, unito alla considerazione che in molti casi i cittadini fruiscono di servizi pubblici in territori diversi da quello di propria residenza (si pensi al trasporto pubblico per i pendolari), rende del tutto insufficiente la tutela costituita dal controllo politico dei cittadini sulle proprie amministrazioni locali (Napolitano). È dunque acclarato che servano nuovi e più incisivi strumenti di tutela e forme di controllo che non si risolvano nel rapporto tra ente locale e soggetto affidatario (e, dunque, nel contratto di servizio). Dalla lettura dell’art. 23-bis emerge anzitutto la mancanza di garanzie sulla qualità del servizio: almeno in questa prospettiva, il disegno di legge Lanzillotta raggiungeva un miglior risultato – almeno negli intenti – poiché condizionava il perdurare dell’affidamento al positivo riscontro della qualità del servizio, come valutato dagli utenti (in base a sondaggi e analisi di mercato, peraltro di difficile realizzazione).
In secondo luogo, colpisce il fatto che manchino forme di tutela degli utenti nei confronti degli erogatori dei servizi. L’art. 23-bis contiene qualche riferimento, dal tono piuttosto vago: il primo comma, prevede il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi, come anche il diritto al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’art. 117, c. 2, lett. m). Tali richiami, tuttavia, sembrano maggiormente volti a fondare la competenza del legislatore statale, che non a conferire concrete e specifiche garanzie agli utenti. Analoga considerazione riguarda la previsione, sempre contenuta nel primo comma, di un “adeguato livello di tutela degli utenti”: l’espressione, che riprende lo stile redazionale di molte previsioni comunitarie, nulla aggiunge agli strumenti esistenti, neppure – si deve credere – sotto il profilo dei canoni argomentativi della giurisprudenza. E poco di più potranno fare i regolamenti di delegificazione, cui è delegato il compito di “prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi”.
Anche sotto questo profilo è da dire che il disegno di legge Lanzillotta si spingeva oltre, riconoscendo alla Carta dei servizi una posizione centrale: veniva infatti previsto che questa fosse adottata a seguito di intese con le associazioni di categoria, introducendo un forte momento partecipativo, finalizzato all’emersione delle istanze degli utenti. Sotto il profilo contenutistico, poi, la Carta dei servizi avrebbe dovuto prevedere meccanismi di rimborso automatico per gli utenti e specifiche sedi conciliative presso le competenti Autorità indipendenti.
7. Le iniziative locali. In particolare: l’Autorità sui servizi pubblici locali del Comune di Genova.
Nelle pagine che precedono si è avuto modo di segnalare in più punti il carattere non organico della riforma e le numerose zone grigie che necessitano ulteriori interventi di regolazione. Si è anche detto che lo Stato ha giustificato il proprio intervento invocando la tutela della concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni. Se questo è vero, è altrettanto vero che i servizi pubblici locali rientrano nella tradizionale sfera degli enti comunali, e che il nuovo principio di pluralismo istituzionale paritario (con il corollario della pari dignità istituzionale), sancito dall’art. 114 della Costituzione, impone di guardare con maggiore sospetto alle invasioni di campo da parte del legislatore statale, non solo nei confronti delle competenze regionali, ma anche di quelle comunali.
Alcune amministrazioni territoriali, interpretando in modo forte le proprie prerogative, e mostrando di dare un significato sostanziale al principio di sussidiarietà verticale, hanno messo in cantiere regolamenti e atti generali volti a completare la disciplina dei servizi pubblici locali. L’iniziativa che suscita maggior interesse è quella del Comune di Genova che, con delibera n. 77 del 4 novembre 2008, ha istituito l’Autorità sui servizi pubblici locali del Comune. Tale soggetto ha compiti di regolazione, vigilanza e controllo nei confronti di tutti i “servizi pubblici locali del Comune di Genova”, con tale formula intendendosi sia quelli erogati direttamente dall’amministrazione, che quelli affidati a soggetti terzi.
Le funzioni attribuite all’Autorità sono alquanto vaste: l’art. 2 del regolamento, approvato con la citata delibera, prevede – tra le altre – la vigilanza sullo svolgimento e sulle modalità di erogazione dei servizi, con potere di accesso e di acquisizione della documentazione; la proposta al Consiglio comunale degli standard di qualità dei servizi, previa audizione delle associazioni di utenti; la pubblicizzazione delle condizioni di svolgimento dei servizi pubblici locali; la valutazione della conformità delle Carte dei servizi con i contratti di servizio; la verifica dell’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi dei servizi, come stabiliti nei contratti di servizio; la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti, nonché la verifica periodica del grado di soddisfazione degli utenti medesimi; l’esercizio di poteri di verifica e di sindacato ispettivo nei confronti dei gestori dei servizi; la predisposizione di schemi-tipo delle concessioni, dei bandi di gara e dei contratti di servizio, ed altro ancora.
Merita attenzione la previsione dell’art. 3, c. 2, del Regolamento, che consente all’Autorità genovese di comminare sanzioni ai soggetti erogatori di servizi pubblici, a condizione che tale ipotesi sia prevista nei contratti di servizio. Il potere sanzionatorio dell’Autorità, pertanto, ha fondamento contrattuale: tale originale scelta è condivisibile, anche perché soluzioni diverse avrebbero comportato irrisolvibili problemi circa il rispetto del principio di legalità della sanzione amministrativa. La soluzione, immaginando che la clausola sanzionatoria venga inserita in tutti i contratti, può rappresentare una valida via d’uscita per garantire all’Autorità una deterrente capacità afflittiva anche in assenza di un’apposita previsione di legge.
Quanto alla struttura dell’Autorità, il Regolamento adottato dal Consiglio comunale prevede un organo collegiale, formato da tre soggetti. Alcuni studiosi hanno ipotizzato una soluzione monocratica (Napolitano), sottolineandone la maggior snellezza ed efficienza. Ciò è senz’altro vero, anche se un collegio di tre persone può garantire la presenza in seno all’Autorità delle diverse competenze e sensibilità (anzitutto giuspubblicistiche, ma anche giusprivatistiche ed economiche) che si intrecciano sul terreno dei servizi pubblici locali.
Le altre previsioni in tema di struttura dell’organo si segnalano vuoi per l’eccessiva vaghezza, vuoi per l’eccessiva durezza. Nella prima categoria rientrano i requisiti richiesti per essere eletti membri dell’Autorità: l’art. 4 del Regolamento, infatti, si limita a prevedere che i membri siano “cittadini e cittadine dotati/e di riconosciuta professionalità e competenza”. Simile previsione, di fatto, lascia al Consiglio comunale, chiamato ad eleggere i membri dell’Autorità, un ampio margine di discrezionalità. In altre parole, il rischio è che una previsione a maglie così larghe incoraggi nomine basate più su motivazioni politiche che su valutazioni tecniche. Un bilanciamento a questo rischio, tuttavia, è costituito dalla previsione di una maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali per i primi due scrutini, di una maggioranza dei tre quinti al terzo scrutinio, e della maggioranza assoluta solamente a partire dal quarto scrutinio. Ulteriore apprezzabile bilanciamento è rappresentato dal fatto che i membri siano scelti tra i soggetti che abbiano presentato pubblica candidatura, con invio del proprio curriculum vitae agli uffici del Consiglio comunale.
Fra le previsioni che paiono eccessivamente rigide vi è quella delle incompatibilità. L’art. 5 del Regolamento, infatti, prevede che i membri dell’Autorità sui servizi pubblici locali non possano esercitare “a pena di decadenza, attività professionali o di consulenza negli enti o società, anche controllate e/o partecipate, nei cui confronti la stessa Autorità espleta le proprie funzioni, né possono essere amministratori, dipendenti o consulenti di enti o società, anche controllate e/o partecipate, i cui interessi siano confliggenti con quelli sottoposti alla attività di istituto dell’Autorità”. Senza indugiare su alcuni dubbi derivanti dalla scarsa qualità redazionale della disposizione, risulta tuttavia evidente la volontà di dare vita ad un sistema di incompatibilità decisamente restrittivo. E più rigide ancora sono le previsioni contenute nel comma successivo: viene infatti previsto che tali incompatibilità si estendano anche ai cinque anni precedenti e ai cinque anni successivi al mandato, a pena di decadenza. Pur dovendosi lodare la volontà di scongiurare il rischio di conflitti di interessi tra i soggetti chiamati ad una tanto delicata opera di regolazione e di controllo e il settore oggetto delle attenzioni dell’Autorità, tale previsione pare francamente eccessiva, anche perchè porta i membri dell’Autorità a non poter esercitare attività professionali nell’ampio settore dei servizi pubblici per un periodo oscillante dai quindici ai vent’anni, se ai dieci di incompatibilità si sommano i cinque (più un possibile rinnovo) di durata del mandato. In più, si noti, non è affatto chiaro come possa essere sanzionata la violazione del divieto in relazione ai cinque anni successivi alla scadenza della carica: se infatti per le altre ipotesi è applicabile l’efficace deterrente della decadenza, certo questa soluzione non è praticabile per chi abbia già concluso il proprio mandato fisiologicamente.
A mo’ di prima conclusione si deve guardare con grande interesse all’esperimento genovese (che potrà giovarsi dell’esperienza maturata in altre realtà, come quella romana e torinese), anche se – come spesso avviene in questi casi – la reale portata dell’innovazione potrà essere valutata solo una volta che l’Autorità sarà stata costituita e avrà iniziato a muovere i primi passi. Come nei più blasonati esempi nazionali e comunitari, infatti, spesso l’autorevolezza si lega più alle persone che agli organi.
*di Lorenzo Cuocolo
Professore associato di Diritto pubblico comparato
nell’Università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano
|